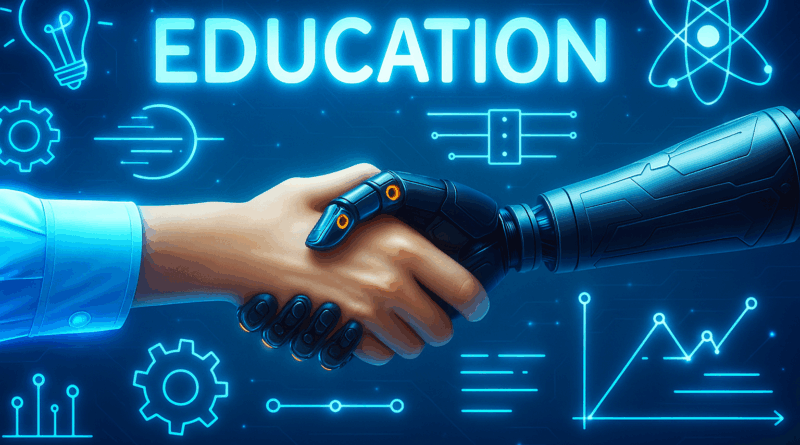Intelligenza Artificiale a scuola: opportunità e limiti del nuovo regolamento
Mentre il Ministero, in ritardo di anni, affronta il problema della IA a scuola con linee guida e strumenti di controllo poco chiari, gli studenti usano già l’IA ogni giorno. Il vero rischio? Lasciare che la scuola resti a guardare.
Tempo di lettura 12 minuti
Partiamo da qui. Il 29 agosto 2025 il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha pubblicato le “Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche”, aprendo una nuova fase nell’uso dell’IA nelle aule italiane.
Con la Legge 23 settembre 2025, n. 132, la scuola italiana entra ufficialmente nell’era dell’intelligenza artificiale. Il provvedimento, approvato dopo mesi di confronto tra Governo, università e mondo produttivo, segna un cambio di paradigma per tutto il sistema educativo: dall’infanzia all’università, l’obiettivo è formare cittadini e professionisti capaci di comprendere, usare e governare le tecnologie del futuro.
Uno dei punti chiave è l’attenzione agli studenti ad alto potenziale cognitivo, per i quali l’articolo 22 introduce percorsi personalizzati e attività mirate a valorizzare il talento, superando il modello standardizzato dell’apprendimento.
Parallelamente, la legge punta su una diffusa alfabetizzazione all’intelligenza artificiale: studenti e docenti, di ogni ordine e grado, saranno coinvolti in corsi e laboratori per comprendere il funzionamento, le opportunità e i rischi delle nuove tecnologie.
Ampio spazio viene dato anche al rafforzamento delle competenze STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), ma con una visione integrata che include le discipline artistiche e creative: un ponte tra razionalità e immaginazione, nella convinzione che l’innovazione nasca dall’incontro tra scienza e cultura.
La riforma tocca anche l’università e l’alta formazione artistica e musicale (AFAM), dove nascono nuovi corsi dedicati all’uso consapevole dell’intelligenza artificiale, sia dal punto di vista tecnico che etico.
Infine, la legge scommette sulla ricerca e sulla collaborazione tra università, ITS e imprese, creando un ecosistema in cui formazione e innovazione procedano di pari passo, con l’obiettivo di preparare una nuova generazione di professionisti in grado di guidare il cambiamento tecnologico.
Dopo una lettura, per quanto a sommi capi, la Legge 132 non si limita a introdurre l’IA nelle aule: mira a trasformare la scuola in un laboratorio di futuro, dove tecnologia, talento e umanità possano crescere insieme.
Tutto bello forse, ma finalmente un passo necessario, che tuttavia lascia sul tavolo alcune questioni cruciali.
Quindi l’IA deve essere al servizio di studenti e insegnanti, rispettare la privacy, garantire trasparenza e supervisione umana, e prevenire discriminazioni. Sono indicazioni etiche solide che pongono la persona al centro, non la macchina. L’obiettivo di personalizzare l’apprendimento e supportare studenti con bisogni speciali è lodevole, così come l’attenzione alla formazione continua dei docenti attraverso corsi e workshop obbligatori.
Eppure, non mancano le criticità. La distanza tra teoria e pratica resta evidente: le linee guida si concentrano sugli aspetti normativi e offrono pochi esempi concreti su come integrare l’IA nella didattica quotidiana. Un docente potrebbe ritrovarsi senza indicazioni operative su come utilizzare strumenti di IA per migliorare l’apprendimento o gestire la classe in modo efficace.
Un altro punto debole riguarda la valutazione dell’impatto. La legge prevede infatti l’uso del cosiddetto FRIA, il Fundamental Rights Impact Assessment, uno strumento pensato per analizzare se l’adozione di sistemi automatizzati può violare diritti fondamentali, prevenendo discriminazioni o rischi per la privacy. Il problema è che il FRIA resta un esercizio teorico, senza indicazioni chiare su come tradurlo in pratiche concrete per monitorare gli effetti dell’IA sugli studenti, sulla qualità dell’insegnamento e sulla sicurezza dei dati.
Immaginate che la scuola voglia usare un robot o un programma di intelligenza artificiale per aiutare gli studenti nello studio. Prima di accenderlo, bisogna capire se potrebbe creare problemi, come trattare ingiustamente qualcuno, dare risultati sbagliati o condividere dati privati. Il FRIA, o Fundamental Rights Impact Assessment, serve proprio a questo: è uno strumento che permette di valutare in anticipo se l’uso dell’IA rischia di violare i diritti fondamentali degli studenti, dalla privacy all’inclusione, evitando discriminazioni o conseguenze indesiderate.
Il FRIA non è un programma che funziona da solo o che applica automaticamente delle regole: non è un software che scansiona la classe o controlla il robot. Piuttosto, è una procedura da compilare e interpretare, inserita all’interno del processo di introduzione dell’IA nella scuola. Le linee guida ministeriali lo collocano come fase preventiva obbligatoria, prima che qualsiasi sistema di IA venga utilizzato, e serve a guidare insegnanti e dirigenti nel valutare rischi e criticità.
In pratica, il FRIA funziona come una specie di checklist avanzata che segnala i possibili problemi. Gli educatori devono leggere attentamente i risultati, interpretare i rischi e decidere quali precauzioni adottare per proteggere gli studenti. Non avvisa da solo e non corregge automaticamente eventuali errori dell’IA: segnala semplicemente le criticità e aiuta a pianificare interventi per ridurre i rischi. Per questo motivo, anche se il FRIA è uno strumento prezioso, la sua efficacia dipende molto dalla capacità di chi lo usa di trasformare le valutazioni in azioni concrete.
La formazione dei docenti, seppur prevista, presenta modalità e tempi ancora vaghi. L’uso efficace dell’IA non si improvvisa: servono supporto concreto, esempi operativi e strumenti già pronti per l’uso in aula. Per rendere l’IA davvero utile, le scuole dovrebbero partire da progetti pilota, sperimentando tutor virtuali per studenti con difficoltà di apprendimento o strumenti che automatizzino alcune attività ripetitive, così da trasformare i principi etici in esperienze quotidiane. Sarebbe utile creare guide operative passo passo per ciascun strumento digitale, così che il docente possa comprendere velocemente come integrarlo nella lezione. Allo stesso tempo, il FRIA dovrebbe evolversi da documento teorico a checklist pratica, con indicatori aggiornabili per monitorare privacy, inclusione e impatto educativo.
La formazione dovrebbe andare oltre i corsi teorici, prevedendo workshop pratici, laboratori di co-progettazione e momenti di tutoraggio tra docenti più esperti e colleghi meno avvezzi all’uso dell’IA. E non meno importante è il coinvolgimento degli studenti: educarli a un uso consapevole dell’IA può sviluppare il pensiero critico e farli partecipare attivamente nella valutazione degli strumenti digitali, rendendo l’innovazione più concreta e responsabile.
Quale intelligenza artificiale scegliere a scuola? Tra regole, privacy e scelte consapevoli
Dopo la pubblicazione delle Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, le scuole italiane si trovano davanti a una nuova sfida: scegliere quale intelligenza artificiale utilizzare. Non è una scelta banale, perché in gioco ci sono non solo la qualità dell’apprendimento, ma anche la tutela dei dati, i costi e i possibili conflitti commerciali tra piattaforme.
Le nuove linee guida stabiliscono che l’uso dell’IA a scuola debba rispettare alcuni principi fondamentali: trasparenza, sicurezza, supervisione umana e rispetto della privacy, in linea con il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR). Ma tradurre questi principi in scelte concrete non è semplice. Oggi esistono decine di piattaforme che promettono di “rivoluzionare” la didattica, dai tutor virtuali che spiegano le lezioni agli assistenti amministrativi che semplificano il lavoro delle segreterie. Tuttavia, non tutte offrono le stesse garanzie e molte operano in un contesto commerciale competitivo, dove la scuola rischia di diventare un semplice cliente più che un soggetto tutelato.
Per scegliere la piattaforma giusta, la prima cosa da fare è capire cosa serve davvero. Ogni scuola deve definire i propri obiettivi: vuole un supporto per l’apprendimento personalizzato? Un sistema che aiuti nella valutazione? O uno strumento per l’organizzazione interna? Solo dopo aver chiarito gli scopi si può procedere a valutare le opzioni disponibili.
La seconda fase è verificare la conformità legale. Una piattaforma che tratta dati di studenti, spesso minorenni, deve garantire standard molto elevati di protezione. È importante capire dove vengono conservati i dati (in Europa o fuori dall’UE), se vengono crittografati, se sono condivisi con terze parti e chi ne è il titolare. Ogni scuola dovrebbe chiedere una dichiarazione scritta di conformità al GDPR e alle linee guida del Garante della Privacy.
Un altro elemento da considerare riguarda i conflitti commerciali e la trasparenza economica. Alcune aziende offrono versioni gratuite o fortemente scontate per attrarre nuovi utenti, ma poi vincolano le scuole a contratti difficili da disdire o impongono costi aggiuntivi per l’uso avanzato delle funzioni. Prima di firmare, è fondamentale leggere con attenzione le clausole sui costi, sulla durata delle licenze e sul diritto di uscita dal servizio. In altre parole, la scuola deve restare libera di cambiare piattaforma senza rischiare di perdere dati o risorse.
Per questo motivo, sarebbe utile che il Ministero o gli Uffici scolastici regionali offrissero liste di piattaforme certificate, ovvero strumenti già verificati per sicurezza, affidabilità e rispetto dei dati sensibili. Allo stesso modo, la formazione dei docenti dovrebbe includere corsi pratici per imparare a usare e valutare le tecnologie di IA, così da rendere le scuole più autonome nelle scelte.
In definitiva, la domanda “quale IA scegliere?” non ha una risposta unica. Ogni istituto deve fare una valutazione attenta, basata su trasparenza, necessità didattiche e tutela degli studenti. L’intelligenza artificiale può davvero migliorare la scuola, ma solo se la scelta delle piattaforme sarà guidata da criteri etici e pratici, e non solo da mode tecnologiche o logiche di mercato.
Quando l’IA a scuola diventa un rischio: cosa succede se la legge viene applicata male
L’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle scuole italiane apre grandi opportunità, ma anche nuovi rischi. Le linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito stabiliscono principi precisi, soprattutto in tema di sicurezza, trasparenza e tutela dei dati personali. Tuttavia, se questi principi vengono ignorati o applicati in modo superficiale, le conseguenze possono essere significative — per gli studenti, per i docenti e per l’istituto stesso.
Il primo rischio riguarda la violazione della privacy. Molti sistemi di intelligenza artificiale raccolgono, elaborano e memorizzano dati sensibili, come risultati scolastici, comportamenti online, perfino emozioni o tempi di attenzione. Se una scuola adotta una piattaforma non conforme al GDPR o non esegue correttamente il FRIA, può incorrere in sanzioni da parte del Garante della Privacy. Le multe possono arrivare fino a cifre rilevanti di euro o al 4% del bilancio annuale dell’ente coinvolto, ma più grave ancora è il danno reputazionale: un istituto che perde la fiducia delle famiglie o che finisce sulle cronache per un uso improprio dei dati rischia di compromettere la propria credibilità educativa.
Un secondo pericolo è quello della discriminazione algoritmica. Se il sistema di IA non è stato verificato a fondo, può imparare schemi sbagliati e riprodurre pregiudizi: ad esempio, assegnare punteggi inferiori a determinati gruppi di studenti o favorire chi si esprime in un certo modo. In assenza di un’adeguata supervisione umana, l’IA potrebbe finire per amplificare le disuguaglianze anziché ridurle. Anche in questo caso, la responsabilità ricade sulla scuola, che ha il dovere di controllare che ogni tecnologia sia imparziale e verificabile.
Un terzo rischio è di tipo educativo. Se l’IA viene introdotta senza una strategia pedagogica chiara, può trasformarsi da strumento di apprendimento a scorciatoia cognitiva. Gli studenti potrebbero usarla per evitare lo sforzo creativo o per sostituire il pensiero critico con risposte automatiche. Allo stesso modo, un uso eccessivo da parte dei docenti — per esempio nella correzione automatica dei compiti o nella valutazione — rischia di ridurre la relazione educativa, che resta il cuore del processo formativo.
Ci sono poi i rischi amministrativi e contrattuali. Molte piattaforme di IA operano con licenze annuali o abbonamenti legati a società straniere. Se la scuola non valuta con attenzione le clausole, può ritrovarsi vincolata a contratti difficili da interrompere o a costi imprevisti. Inoltre, in caso di violazione dei dati o malfunzionamento del sistema, la responsabilità legale può ricadere sull’istituto, che ha approvato l’uso dello strumento senza adeguate verifiche.
Infine, non va dimenticato il rischio di mancanza di formazione. Un corpo docente che non conosce il funzionamento delle piattaforme IA può utilizzarle in modo improprio, inserendo dati errati o interpretando male i risultati. Senza competenze specifiche, anche le tecnologie più avanzate diventano strumenti fragili.
Tra attesa e realtà: perché la scuola non può permettersi di ignorare l’IA
La verità è che l’intelligenza artificiale è già entrata in classe, anche se la scuola non l’ha ancora ufficialmente invitata. Gli studenti la usano per scrivere temi, tradurre testi, risolvere esercizi o persino generare immagini e video. Lo fanno con curiosità, ma anche con leggerezza, spesso senza conoscere i rischi legati alla privacy, alla disinformazione o all’uso improprio dei contenuti.
In questo scenario, limitarsi ad “aspettare” che il quadro normativo sia perfetto non è una soluzione. Anzi, sarebbe un errore. Il rischio di non introdurre l’IA a scuola è che l’educazione resti indietro, lasciando gli studenti soli davanti a uno strumento che ha già cambiato il loro modo di apprendere, comunicare e pensare.
Ciò che serve oggi non è una corsa all’adozione di ogni nuova piattaforma, ma una strategia di alfabetizzazione digitale. La scuola deve diventare il luogo dove si impara non solo a usare l’intelligenza artificiale, ma anche a capirla, interrogarla e valutarla criticamente.
Insegnare agli studenti come funziona un algoritmo, perché può sbagliare, cosa sono i bias o come si tutelano i propri dati, è un atto educativo e democratico, non tecnico.
In attesa che le leggi si consolidino, che il Ministero definisca elenchi di piattaforme certificate e che il FRIA diventi uno strumento davvero operativo, le scuole possono già cominciare a fare qualcosa di fondamentale: parlare di IA in modo consapevole.
Significa usare gli strumenti disponibili in modo sperimentale, con trasparenza, coinvolgendo i docenti più preparati e guidando gli studenti all’uso responsabile.
Non introdurre l’IA a scuola, oggi, significherebbe lasciare il campo libero all’improvvisazione e alle piattaforme commerciali che si rivolgono direttamente ai ragazzi, senza alcun filtro educativo.
Meglio, quindi, accompagnare il cambiamento, anche con prudenza, ma da protagonisti — non da spettatori.